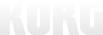Poetry Magnifique
DIGITAL PIANO
Supporto per il suo acquisto
Supporto tecnico
Per saperne di più
Siti correlati
Spiegazione dei brani demo inclusi in Poetry
Spiegheremo ciascuna delle 50 demo musicali di Chopin incluse in Poetry. Nel nome del suono della demo, “P” è suonato su Pleyel (430Hz) e “I” è suonato su Italian Piano.
Commentatore: Aki Fujii
Mazurka

Op. 67: Quattro Mazurche, un viaggio nell’anima di Chopin Questa raccolta, composta da quattro brani scritti in anni diversi, fu curata e pubblicata postuma nel 1855 dal suo amico Julian Fontana. Ogni pezzo riflette un momento intimo della vita del compositore, intrecciando ricordi, emozioni e radici polacche.
Mazurke Op.67
Op. 67: Quattro Mazurche, un viaggio nell’anima di Chopin. Questa raccolta, composta da quattro brani scritti in anni diversi, fu curata e pubblicata postuma nel 1855 dal suo amico Julian Fontana. Ogni pezzo riflette un momento intimo della vita del compositore, intrecciando ricordi, emozioni e radici polacche.
Notturno
Chopin, profondamente colpito dalla musica di Field, ne assimilò lo spirito e lo rifletté nelle proprie opere. Il suo ideale era quello di trasporre nel pianoforte la vocalità lenta e intensa delle arie operistiche, per esprimere emozioni liriche profonde. Così come le serenate — talvolta tradotte come notturni — erano canti d’amore dedicati all’amata sotto le stelle, anche i Notturni di Chopin possono essere letti come confessioni intime, in cui il compositore dà voce alla propria interiorità.

Notturno in si bemolle minore op. 9-1 (Poetry Demo #11)
Quest'opera, che segna l'inizio del genere del notturno, fu composta a Parigi, in Francia, centro musicale finalmente accessibile a lui, e fu dedicata alla sua compagna di una vita Marie, moglie di Camille Pleyel (1788-1855), presidente della società di liuteria Pleyel. Il contrasto tra il primo tema malinconico in si bemolle minore e il secondo tema delicato in re bemolle maggiore è armonizzato magnificamente, con colorature (la parte delle canzoni e delle opere in cui la voce è cantata con ornamenti rotolanti e dettagliati in modo splendidamente veloce) sparse qua e là.
Notturno in mi bemolle maggiore op. 9-2 (Poetry Demo #04)
È uno dei notturni più amati. Il modo in cui la melodia si snoda con ornamenti mutevoli ha una delicatezza e un'eleganza simili al pizzo. Secondo i ricordi degli allievi di Chopin, egli improvvisava gli ornamenti (varianti) ogni volta che suonava. Anche la coda gioiello è affascinante.
Notturno in re bemolle maggiore op. 27-2 (Poetry Demo #40)
Un giorno, le figure più illustri del mondo letterario e musicale si riunirono in un salotto per chiacchierare. Un violinista eseguì un brano di sua composizione, che commosse il pubblico. Chopin, che stava ascoltando la musica, compose questo brano per pianoforte sul momento. I due temi appaiono alternativamente con bellissime variazioni ornamentali, e le sfumature duettistiche del secondo tema aggiungono profondità al brano. Insieme al n. 2, è il notturno più popolare.
Studi
Gli Studi di Chopin: virtuosismo e poesia in forma concertistica Le due raccolte di Studi, Op.10 e Op.25, ciascuna composta da 12 brani, sono troppo artistiche per essere considerate semplici esercizi. Si possono invece definire veri e propri pezzi da concerto, in cui si concentra l’essenza del pianismo chopiniano.
L’idea di comporre questi Studi nacque dopo la stesura dei suoi due ambiziosi concerti per pianoforte, composti all’età di 19 anni. Entrambi sono considerati capolavori, non solo per la loro bellezza musicale, ma anche per il livello tecnico richiesto per eseguirli. Per interpretarli al meglio, è necessario padroneggiare il linguaggio pianistico unico di Chopin.
Fu proprio per trasmettere questo linguaggio e perfezionare la propria tecnica che Chopin decise di comporre gli Studi. In origine li chiamava semplicemente “Esercizi”, fino a quando non furono pubblicati con il titolo di “Études”. Curiosamente, i titoli oggi più noti — come Chanson de l’adieu o Winter Wind — non furono attribuiti da Chopin, ma vennero aggiunti successivamente. È naturale che la magnificenza musicale di questi brani, che supera il confine dell’esercizio tecnico, abbia acceso l’immaginazione collettiva, ispirando nomi che riflettono la vita e la sensibilità del compositore.

Studi Op.10
Quest'opera fu dedicata a Franz Liszt (1811-1886), compositore e pianista di grande popolarità, di un anno più giovane di Chopin, con le parole “À SON AMI” (al mio amico). Chopin non sembrava nutrire grande simpatia per il compositore Liszt, ma ammirava il suo modo di suonare il pianoforte, acclamato come uno dei migliori pianisti dell'epoca. Liszt fu molto contento della dedica dell'opera ed espresse la sua gratitudine con un'esecuzione perfetta.
Studio in Do maggiore Op.10-1 “Cascata” (Poetry Demo #25)
Poiché l'opera è soprannominata “Cascata”, la natura dinamica dei magnifici passaggi della mano destra, che si muovono su e giù con forza propulsiva sulla linea di basso della mano sinistra, è molto impressionante. La mano destra arpeggia costantemente su e giù per quattro ottave, richiedendo indipendenza e ampiezza delle dita della mano destra, nonché flessibilità e libertà di movimento del polso e del gomito. È uno dei brani più difficili da suonare tra i brani di esercitazione.
Studio in mi maggiore op. 10-3 “Chanson de l'adieu” (Dimostrazione poetica n. 01)
Non solo la melodia di questa famosissima canzone è bellissima, ma anche la sua armonia è degna di nota. Chopin, ascoltando il suo allievo suonarla, disse: “Non ho mai scritto una canzone più bella in tutta la mia vita”. “Oh, mia patria! ed esclamò: ”Oh, mia patria!
D'altra parte, la tecnica esecutiva richiede l'abilità di suonare ogni parte vocale della polifonia (musica polifonica) e la tecnica di suonare le note della parte centrale.
Studi Op.25
Gli Studi Op.25: virtuosismo e immaginazione poetica
La raccolta fu dedicata alla contessa Marie d’Agoult (1805–1876), scrittrice e giornalista, compagna di Liszt. In essa si percepisce anche il rispetto di Chopin per Liszt come pianista. La maggior parte dei brani fu composta a Parigi, in un periodo in cui Chopin stava conquistando notorietà come pianista da salotto e insegnante per le élite femminili. Amava eseguirli nei suoi concerti: non erano soltanto materiali didattici per affinare la tecnica, ma anche piccoli gioielli musicali capaci di impreziosire le esibizioni.
Studio in La bemolle maggiore Op.25 n.1 “Arpa eolica” – Poetry Demo #27
Chopin disse a un suo allievo: “Immagina un fanciullo pastorale che suona dolcemente un flauto in una grotta, al riparo da una tempesta imminente.” Per questo motivo il brano è anche chiamato Il fanciullo pastorale.
Il titolo “Arpa eolica” fu invece coniato da Robert Schumann (1810–1856), che vi riconobbe la delicatezza degli accordi dispersi nelle voci interne, simili alle corde di un’arpa mossa dal vento. La grazia della melodia che emerge da questa trama sonora è straordinaria.
Studio in Mi minore Op.25 n.5 – Poetry Demo #28
Un brano che alterna una danza in Mi minore, malinconica ma leggera, a una sezione centrale in Mi maggiore. Qui la mano sinistra intona una melodia dal registro medio-grave, ricca e intensa, simile a un assolo di violoncello, creando un contrasto musicale sorprendente.
Studio in Sol bemolle maggiore Op.25 n.9 “La farfalla” – Poetry Demo #29
L’accompagnamento leggero e oscillante della mano sinistra evoca una farfalla che si posa di fiore in fiore, mentre le rapide ottave della mano destra ricordano il battito delle ali. La sequenza di ottave deve essere eseguita con leggerezza, pur mantenendo la complessità polifonica.
Studio in La minore Op.25 n.11 “Vento d’inverno” – Poetry Demo #30
Dopo un’introduzione solenne, quasi funebre, la musica si trasforma rapidamente in una tempesta impetuosa. La mano sinistra passa dalla gravità iniziale a una melodia dämonisch, mentre la mano destra, con il suo flusso incessante, modula e cambia espressione con drammaticità.
Studio in Do minore Op.25 n.12 “L’Oceano” – Poetry Demo #31
Considerato parallelo al celebre “Rivoluzionario” Op.10 n.12, fu composto nel settembre 1831, in un momento di rabbia e dolore per la caduta di Varsavia sotto l’esercito russo. Gli arpeggi travolgenti esprimono uno stato d’animo estremo e al tempo stesso evocano un’atmosfera potente e sublime, simile al tuono di Zeus. In essi si riflette lo spirito fiero di Chopin. La conclusione in Do maggiore chiude la raccolta con splendore, rendendo questo Studio un finale degno delle due serie di Op.10 e Op.25.
Ballate
La Ballata: poesia e musica intrecciate Il termine ballata indica una forma poetica fiorita nell’Europa medievale. L’istituzione del genere musicale della ballata da parte di Chopin fu influenzata da diversi fattori: la presenza di Adam Bernard Mickiewicz (1798–1855), poeta romantico nazionale polacco; le ballate popolari diffuse nell’area di Varsavia negli anni Venti dell’Ottocento; e le arie di carattere ballatistico presenti nelle grandi opere parigine.
Chopin fu il primo compositore a utilizzare il nome Ballade per un’opera strumentale. Secondo la testimonianza di Robert Schumann, quando Chopin lo visitò a Lipsia nel 1836 e gli fece ascoltare la sua Ballata n.2 ancora incompiuta, gli confidò di essersi ispirato a un poema di Mickiewicz. Questo legame con la poesia romantica polacca conferisce alle Ballate di Chopin un carattere unico: non semplici composizioni pianistiche, ma confessioni musicali che fondono lirismo poetico e virtuosismo strumentale.

Ballata in Sol minore Op.23 – Poetry Demo #38
Si ritiene che sia stata ispirata dall’ultimo episodio del quarto capitolo di
Conrad Wallenrod, il celebre poema drammatico e romanzo storico di Adam Mickiewicz.
L’introduzione di sette battute, eseguita in unisono, colpisce per la sua semplicità: si tratta del sesto grado napoletano della tonalità principale (un accordo maggiore con la fondamentale a semitono sopra la tonica, molto amato dalla scuola napoletana). Questo inizio, velato e misterioso, preannuncia la grande e tragica vicenda che sta per dispiegarsi.
Il primo tema, intriso di malinconia, e il secondo, euforico e luminoso, si alternano con fragilità, bellezza e intensità, creando un racconto musicale ricco di contrasti e di emozioni. La coda, che si estende per circa cinquanta battute, è considerata un autentico capolavoro.
Sintesi dell’episodio di
Conrad Wallenrod
Nel Medioevo, la Lituania perde l’indipendenza dopo la sconfitta contro i Crociati. Il principe Conrad Wallenrod viene fatto prigioniero e cresciuto da un comandante crociato come fosse suo figlio. Divenuto cavaliere valoroso, trama una campagna per la liberazione della sua patria, ma viene infine giustiziato dai Crociati come traditore.
Ballata in Fa minore Op.52 – Poetry Demo #39
Strutturata come una libera sonata con variazioni e forma di rondò, è forse ispirata al poema
Trzech Budrysów di Mickiewicz, sebbene non vi sia certezza. L’opera ha un carattere introspettivo e poetico, pervaso da un sentimento nostalgico che attraversa l’intero brano. Dopo un’introduzione di sette battute, intensa e ricca di emozione, emerge un tema delicato e sommesso, sviluppato in forma di variazione e intrecciato con numerosi passaggi lirici.
Man mano che le variazioni si intensificano, la “storia” sottesa al tema si rivela con sempre maggiore chiarezza.
Composta nel periodo culminante della relazione con George Sand (1804–1876), scrittrice e pioniera del femminismo, questa Ballata è considerata una delle massime espressioni del genio di Chopin, sia dal punto di vista tecnico che pianistico. Dopo questo periodo, la produzione del compositore diminuì sensibilmente.
Sintesi di
Trzech Budrysów
Il vecchio Budrysów di Lituania manda i suoi tre figli in spedizione verso terre diverse: uno in Russia per procurarsi monete d’argento e pellicce pregiate, uno in Prussia per ottenere ambra e tessuti raffinati, e uno in Polonia. Qui i giovani incontrano una donna straordinaria. Al ritorno, ciascuno porta con sé una sposa polacca. Il padre, senza più domande, si prepara a celebrare tre matrimoni.
Polacche
La Polacca: danza nobile e voce della patria
Il termine
Polonaise, che in francese significa “stile polacco”, ha una lunga storia che risale al 1574, quando fu eseguita per celebrare l’ascesa al trono di Polonia di Enrico III. Il ritmo caratteristico della Polacca (
tantaka-tan-tan-tan), in tempo ternario 3/4, si consolidò nel XVIII secolo: un andamento dolce e solenne, accompagnato da passi nobili e aggraziati, che incarnavano dignità e venivano danzati soprattutto nelle corti principesche e aristocratiche.
Già nella prima metà del XVII secolo la danza aveva conquistato l’Europa, entrando nelle opere di grandi compositori come Bach e Mozart. Chopin, nato a Żelazowa Wola, nei pressi di Varsavia, crebbe immerso in questa tradizione: da un lato le mazurche popolari dei villaggi, dall’altro le polacche raffinate delle case nobili e delle corti che frequentava.
Il suo primo brano per pianoforte, la Polacca in sol minore, fu composto all’età di soli sette anni. Con il tempo, la Polacca divenne per Chopin molto più di una forma musicale: un mezzo privilegiato per esprimere la propria identità polacca e il legame indissolubile con la sua patria.

Polacca in La maggiore Op.40 n.1 “Militare” – Poetry Demo #22
Chopin visse immerso nella travagliata storia della Polonia, dalla Terza Partizione del 1795 alla Rivoluzione dei Cadetti di Varsavia del 1830 e alla sua sconfitta l’anno successivo. Il desiderio di rinascita della sua patria lo accompagnò sempre, e la Polacca divenne per lui un mezzo privilegiato per esprimere identità e inviare un forte messaggio al mondo.
La celebre
Polacca Militare si distingue per chiarezza e imponenza. Alla sua pubblicazione fu dedicata a Julian Fontana, amico di Chopin e partecipante alla Rivoluzione dei Cadetti, con l’affettuosa dicitura “ai miei amici”: un tributo che riflette il legame personale e patriottico del compositore.
Polacca in La bemolle maggiore Op.53 “Eroica” – Poetry Demo #23
Il titolo “Eroica” fu probabilmente attribuito in seguito dai suoi allievi. Dopo una vigorosa introduzione di sedici battute, il tema principale si dispiega con nobiltà e solennità, incarnando l’immagine fiera di Chopin.
La sezione centrale, in Mi maggiore, presenta un tema eroico sostenuto da un ostinato di ottave nella mano sinistra, ripetuto con insistenza e forza. La musica raggiunge il culmine proprio su questo motivo, per poi concludersi con una coda brillante, scandita dal ritmo possente della polacca. È uno dei vertici assoluti della produzione chopiniana.
Polacca in Sol minore KK.IIa-1 (Op.posth) – Poetry Demo #42
È la prima opera superstite di Chopin, composta all’età di soli sette anni. Pubblicata inizialmente in un ristretto circolo e poi a lungo perduta, fu successivamente designata come
Op. posth.
La sua semplicità sorprende: già si intravedono i tratti della musicalità che Chopin avrebbe sviluppato in seguito, insieme a un primo sguardo sul suo pianismo, destinato a diventare unico e inconfondibile.
Valzer
I Valzer di Chopin: eleganza aristocratica e pianismo unico
Durante il soggiorno a Vienna, dove rimase per otto mesi prima di trasferirsi a Parigi, Chopin ebbe modo di osservare la popolarità dei valzer di Johann Strauss padre e di Joseph Lanner. In una lettera alla famiglia scrisse con tono critico:
“I viennesi danzano i valzer di Strauss e Lanner all’ora di cena, e li ballano con grande entusiasmo. Ogni brano riceve un fragoroso bravo. È la prova del gusto corrotto del pubblico viennese…”
Da questa esperienza musicale nacque la volontà di creare un linguaggio personale nel genere del valzer. Unendo il suo gusto aristocratico e il suo pianismo raffinato, Chopin trasformò la danza popolare viennese in un’opera d’arte pianistica, lasciando in eredità 19 valzer che ancora oggi incarnano eleganza, intimità e poesia.

Valzer in Mi bemolle maggiore Op.18 “Grand Valse Brillante” – Poetry Demo #12
Primo valzer pubblicato da Chopin, quando era già figura di spicco dell’alta società parigina. Acclamato dalla Gazette Musicale de Paris al momento della pubblicazione, divenne subito popolare. Si apre con una fanfara, seguita da sette temi eleganti e raffinati: un’opera che merita pienamente il titolo di Grand Valse Brillante.
Valzer in La bemolle maggiore Op.34 n.1 “Valse Brillante” – Poetry Demo #13
Composto durante l’estate in cui Chopin si ricongiunse ai genitori in Boemia, ospite della famiglia aristocratica Thun-Hohenstein a Karlovy Vary. I cinque temi musicali, opulenti e luminosi, sembrano riflettere la felicità di quel periodo.
Valzer in Fa maggiore Op.34 n.3 “Valse Brillante” – Poetry Demo #15
Soprannominato du chat, si dice sia stato ispirato da un gattino che correva sulla tastiera. I passaggi rapidi e scherzosi evocano la vivacità di un gatto dispettoso, osservato con dolcezza dallo sguardo di Chopin.
Valzer in Re bemolle maggiore Op.64 n.1 “Petit chien” – Poetry Demo #02
Il motivo circolare richiama l’immagine di un cagnolino che rincorre la propria coda. Chopin, grande amante dei cani, dedicò questo brano al suo affetto per i cuccioli Marquis e Dib, compagni di George Sand.
Valzer in Do minore Op.64 n.2 – Poetry Demo #14
Capolavoro della maturità chopiniana, fonde la mazurca con il ritmo del valzer. Fragile e mutevole, fu pubblicato insieme al Petit chien ed è tra gli ultimi lavori apparsi prima della morte del compositore.
Valzer in La bemolle maggiore Op.69 n.1 “L’Adieu” (Op.posth) – Poetry Demo #16
Composto a Dresda durante la visita alla famiglia Wodzinska, con cui Chopin ebbe un legame affettivo. Maria Wodzinska scrisse “L’Adieu” sul manoscritto, trasformandolo nel Valzer dell’Addio. Pubblicato postumo, conserva il ricordo di un amore sfiorato.
Valzer in Si minore Op.69 n.2 (Op.posth) – Poetry Demo #17
Scritto intorno ai 19 anni, mescola elementi di mazurca e valzer. Il contrasto tra la malinconia del tema principale e la vivacità della sezione centrale crea un equilibrio poetico di grande bellezza.
Valzer in Mi minore KK.IVa-15 (Op.posth) – Poetry Demo #18
Unico nel suo genere, si distingue per passione e ritmo travolgenti. La sezione centrale in Mi maggiore offre una melodia fluida, mentre la coda, potente e brillante, chiude con maestosità.
Valzer in La minore KK.IVb-11 (Op.posth) – Poetry Demo #19
Semplice e intimo, con una melodia delicata che si dissolve sopra l’accompagnamento discreto della mano sinistra. Un brano che sembra una confessione personale di Chopin, fragile e fugace.
Barcarola
.

Barcarola in Fa diesis maggiore Op.60 – Poetry Demo #43
Considerata uno dei vertici assoluti della produzione chopiniana, questa Barcarola è un’opera colma di luce, colore e amore. Dietro la sua bellezza si cela però il senso di solitudine del compositore, segnato dalla separazione da George Sand e da una salute ormai fragile, che lo rendeva consapevole della propria mortalità. Era il 1845, appena tre anni prima della sua morte.
La Barcarola nasce come imitazione del canto dei gondolieri veneziani. L’accompagnamento della mano sinistra evoca la calma superficie dell’acqua, mentre la melodia si sviluppa in un elegante duetto amoroso, che progressivamente si trasforma in un’improvvisazione di grande virtuosismo. Le delicate variazioni armoniche e le raffinate modulazioni creano un ricco gioco di colori, mentre l’uso del contrappunto aggiunge profondità e intensità.
Il brano si chiude con una coda meditativa e silenziosa, che culmina in un glorioso fortissimo: un finale che suggella la grandezza di una delle opere più intime e sublimi di Chopin.
Berceuse
.

Berceuse in Re bemolle maggiore Op.57
In un primo abbozzo, il titolo appariva come
Variantes, ma fu modificato l’anno successivo, durante il soggiorno a Nohant nella villa di George Sand, dopo una prova eseguita dallo stesso Chopin.
Il brano, di apparente semplicità, appartiene al periodo aureo della maturità del compositore. La sua delicatezza e la sua ispirazione lo rendono un’opera unica, capace di restituire al pianista e all’ascoltatore la sensazione intima dei tasti sfiorati dalle dita di Chopin.
Fantasia-Improvviso
.

Fantaisie-Impromptu in Do diesis minore Op.66 – Poetry Demo #03
È noto che Chopin fosse un perfezionista al punto da chiedere alla famiglia e agli allievi di distruggere tutte le opere prive di numero d’opus. Per ragioni non del tutto chiare, questa composizione non fu mai pubblicata durante la sua vita. Dopo la sua morte, fu l’amico d’infanzia Julian Fontana — anch’egli compositore a darla alle stampe, attribuendole il titolo di Fantaisie-Impromptu. Nonostante l’incertezza sulle motivazioni della mancata pubblicazione, il brano è oggi tra i più celebri e amati del repertorio chopiniano.
La struttura musicale si articola in quattro momenti:
- Parte principale: un vorticoso intreccio di note in ritmi incrociati, di grande brillantezza tecnica.
- Sezione centrale: una melodia dolce e delicata in Re bemolle maggiore, che canta con intimità lirica.
- Ripresa: ritorno del tema iniziale, con la sua energia virtuosistica.
- Conclusione: un epilogo silenzioso e meditativo, che richiama il tema della sezione centrale, chiudendo il brano con poesia e raccoglimento.
Preludi
Nell’inverno del 1838, George Sand lasciò Parigi con i suoi figli e con Chopin, già provato dalla salute fragile, insieme al figlio Maurice che soffriva di reumatismi. La famiglia si rifugiò sull’isola di Maiorca, dal clima mite del Mediterraneo. Fu proprio durante questo soggiorno che Chopin completò i 24 Preludi Op.28, una delle raccolte più straordinarie della sua produzione.
La serie percorre tutte le tonalità, alternando maggiore e minore secondo il circolo delle quinte: da Do maggiore a La minore, da Sol maggiore a Mi minore, e così via, fino a coprire l’intero spettro tonale. L’idea sembra derivare dall’unico spartito che Chopin portò con sé a Maiorca: il Das Wohltemperirte Clavier di Johann Sebastian Bach, che comprende 24 preludi e fughe nei due volumi.
È evidente come Chopin abbia tratto profonda ispirazione da Bach, trasformando il modello in una raccolta personale e poetica, dove ogni preludio diventa un microcosmo musicale, capace di racchiudere emozioni e atmosfere uniche.

Preludio in Do maggiore Op.28 n.1 – Poetry Demo #06
Un vero “Ode an Bach”: richiama il Preludio in Do maggiore dal primo volume del Das Wohltemperirte Clavier. La polifonia limpida e affascinante sembra un tributo di Chopin al maestro barocco.
Preludio in Mi minore Op.28 n.4 – Poetry Demo #07
La mano sinistra disegna una progressione cromatica discendente, come lacrime che scendono, scandite da accordi. La melodia della mano destra esprime un dolore intimo e struggente. Questo preludio fu eseguito all’organo della chiesa della Madeleine a Parigi durante il funerale di Chopin.
Preludio in Si minore Op.28 n.6 – Poetry Demo #08
Il canto malinconico della mano sinistra ricorda il timbro del violoncello, strumento amatissimo da Chopin. L’ostinato di ottavi della mano destra e la scansione regolare dei quarti evocano una marcia funebre solenne. Anche questo preludio fu eseguito al funerale del compositore.
Preludio in La maggiore Op.28 n.7 – Poetry Demo #09
Un breve brano di 16 battute, Andantino, che unisce la nobiltà di un corale alla leggerezza di una mazurca. La semplicità della scrittura si accompagna a una bellezza melodica e armonica straordinaria.
Preludio in Re bemolle maggiore Op.28 n.15 “La goccia di pioggia” – Poetry Demo #10
Celebre con il soprannome Raindrop, legato al racconto di George Sand in Histoire de ma vie. Le note di ottavi incessanti evocano il suono della pioggia, mentre la sezione centrale esplode in un dramma emotivo, modulando da La bemolle a Sol diesis. Il ritorno alla calma finale sembra riflettere lo stato d’animo tormentato di Chopin, sospeso tra realtà e sogno.
Preludio in Si bemolle minore Op.28 n.16 – Poetry Demo #32
Dopo un’introduzione di accordi violenti, la mano destra si lancia in rapide figurazioni, sostenute dal battito regolare della sinistra. La musica cresce come una tempesta, rivelando l’energia magmatica e inquieta della mente di Chopin.
Preludio in Re minore Op.28 n.24 – Poetry Demo #33
Ultimo della raccolta, Allegro appassionato. Un dramma spettacolare e disperato, che culmina nel grido intenso della melodia della mano destra. La conclusione, con tre colpi fff sulla nota più grave della tonalità, trascina l’ascoltatore in un abisso insondabile: un finale grandioso e sconvolgente.
Sonate
Le Sonate per pianoforte di Chopin
Chopin compose tre sonate per pianoforte nel corso della sua vita. Pur avendo appreso fin da giovane le tecniche compositive dai grandi modelli classici, la rigidità della forma-sonata sembrava talvolta limitare la sua creatività.
La Sonata n.1, scritta in gioventù, risente maggiormente della struttura tradizionale. Le Sonate n.2 e n.3, invece, adottano uno stile più libero e personale, rivelando una straordinaria originalità. Questi due lavori sono unanimemente considerati tra i vertici della produzione chopiniana, capaci di fondere rigore formale e lirismo poetico con un pianismo di eccezionale intensità.

Sonata n.2 in Si bemolle minore Op.35 – III movimento “Marcia funebre” – Poetry Demo #44
Il ritmo pesante e puntato evoca i passi silenziosi e solenni di un corteo funebre. La sezione centrale, in cui la melodia si innalza con calma, come avvolta da una luce gentile, raggiunge una sublimità che sembra elevarsi senza fine verso il cielo.
Il contrasto tra la gravità della marcia e la serenità della parte centrale intensifica il pathos dell’opera, trasformando questo movimento in una delle pagine più celebri e toccanti di Chopin, capace di fondere dolore e trascendenza in un unico, indimenticabile quadro musicale.
Sonate III
Sonata n.3 in Si minore Op.58 – Poetry Demos #45–48
Nel 1844 Chopin attraversava un periodo difficile: la salute minata dalla tubercolosi e la morte del padre Mikołaj lo avevano profondamente segnato. Fu George Sand a organizzare il ricongiungimento con la sorella Ludwika, dopo quattordici anni di lontananza. Questo incontro ridiede al compositore nuova energia vitale, e proprio in questo contesto nacque la sua opera più ampia, classica e profonda: la Sonata n.3 in Si minore Op.58.
-
I movimento – Allegro maestoso (Poetry Demo #45)
Si apre con un tema discendente che sembra proclamare con forza un messaggio solenne. È un inizio dichiarativo, che stabilisce subito il tono drammatico e monumentale dell’opera. -
II movimento – Scherzo (Poetry Demo #46)
Il tema dello scherzo corre vorticosamente in tutte le direzioni, come in cerca di stabilità. Il contrasto con il trio, calmo e polifonico, è affascinante: un dialogo tra frenesia e quiete. -
III movimento – Largo (Poetry Demo #47)
L’ultima nota del secondo movimento (Mi bemolle) si trasforma enharmonically in un doppio diesis, introducendo un’atmosfera tesa in Sol diesis minore. Da qui la musica modula a Si maggiore, come una luce che sorge dolcemente, prima di intonare un cantabile di straordinaria bellezza. La sezione centrale in Mi maggiore, con arpeggi simili a un’arpa, aggiunge un tocco sognante e malinconico. -
IV movimento – Finale (Poetry Demo #48)
Dopo un’introduzione cromatica ascendente, appare il tema di rondò, acceso da un fervore quasi febbrile. Il tema si espande progressivamente, arricchendosi di volume e splendore, intervallato da passaggi brillanti della mano destra. La coda in Si maggiore conclude con magnificenza, come campane di vittoria che risuonano con entusiasmo.
Largo
.

Largo in Mi bemolle maggiore KK.IVb-5 – Poetry Demo #50
Uno degli ultimi lavori di Chopin, scoperto e pubblicato a Parigi soltanto nel 1938, è un brano dal carattere corale. In esso il compositore aggiunge armonie alla melodia del canto patriottico Boże, coś Polskę ( Dio salva la Polonia).
La semplicità della scrittura si unisce a un profondo valore simbolico: un omaggio alla patria amata, che Chopin non poté mai rivedere, e un segno della sua spiritualità negli ultimi anni di vita. Questo Largo rappresenta una pagina intima e solenne, sospesa tra fede, nostalgia e identità nazionale.
Scherzo
.

Scherzo in Si bemolle minore Op.31 – Poetry Demo #24
È il più noto e familiare dei quattro Scherzi di Chopin. L’apertura, con un motivo di terzine sussurrate e due idee contrastanti, esplode improvvisamente in accordi fortissimo. Secondo l’allievo Lenz, Chopin affermò che questo inizio “deve essere una domanda… e deve avere l’atmosfera di una sala dei morti”.
Dopo questa introduzione drammatica, il tema in Re bemolle maggiore porta un clima luminoso ed esaltante, con il carattere tipico dello scherzo inteso come gioco musicale. Il secondo tema, in Sol bemolle maggiore, si innalza con grazia sopra gli arpeggi leggeri della mano sinistra.
La sezione centrale è un caleidoscopio musicale: da un corale meditativo in La maggiore con recitativo, a una melodia in stile aria in Do diesis minore, fino a un passaggio di coloratura in Mi maggiore. Nella seconda parte, i motivi si susseguono come un torrente, con la varietà e la ricchezza di un’opera teatrale.
Dopo la ripresa del materiale iniziale e una coda rapida e incalzante, il brano si conclude con gli accordi trionfali in Re bemolle maggiore, che risuonano con entusiasmo e splendore.
Riferimenti bibliografici
- Koji Shimoda, Chopin: To Listen, To Play. Commentary on Chopin's Complete Works, Chopin Ltd., 1997.
- Piano Music Encyclopedia “Works Edition”, edizione contemporanea a cura di Geijutsu Gendaisha, Zen Ongaku Publishing Co., Ltd., 1982.
- Chopin from the viewpoint of a pupil: His piano pedagogy and performance aesthetics.
- Chopin: A Creator of Solitude. Person, Work, and Image.
- Yuko Kosaka, Chopin, Ongaku no Tomosha, 2004.